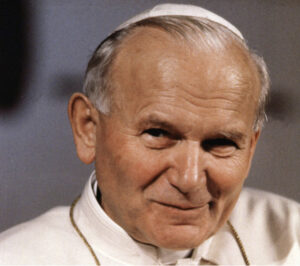di Gian Piero Stefanoni
“se lo sguardo è un quieto abisso/recato sulla palma aperta”
“Piegarsi e poi lentamente salire/senza sentire in quel riflusso i gradini/sui quali è disceso tremando-/solo l’anima, l’anima dell’uomo immersa in una minuscola goccia,/l’anima rapita dalla corrente”. Così nel 1946 il giovane ma non più giovanissimo Karol Wojtyla a pochi mesi dall’ordinazione sacerdotale invocava in quel Canto del Dio nascosto che già nel titolo racchiudeva in sé nella sua ricerca il processo di uno sguardo appassionatamente rivolto a un divino attivamente presente nel quotidiano operare dell’uomo. Un Dio condividente e condiviso (finanche in poesia) tra gli operai delle cave di pietra di Zakrzowek e nella fabbrica di Solway ma anche un Dio come sappiamo in quegli anni restituito al silenzio nel contraccambio di un ascolto che non ha, non può più domande. Di quali gradini allora, di quale corrente e verso quale atrio (mai più nel giardino?) ci parlano questi versi? Forse dell’uomo (mai più nel giardino) la tentazione dei primi giorni nell’eterna primigenia solitudine, il pensarsi ancora soli, per sempre soli, nel flusso di un buio appunto dove luce non buca e vita non appare. Oppure, per quanto dato, sordi a questo, memori di un accordo che non è possibile sciogliere (“perch’io non vada errando in qua e in là/dietro a dei greggi che non sono tuoi” per dirla col “Cantico dei Cantici”), pur sfigurati o perché sfigurati, consapevoli- e vivi- nella libertà del vortice fino all’apparire, al pronunciare partecipato del nome. Quel nome nel cui Corpo si ha di nuovo corpo nella grata pienezza degli amati.
L’uomo e il poeta, il sacerdote non hanno dubbi ma sanno che il movimento, nell’assenso, è all’interno di sé, di una verità che procede da uno svuotamento in quella rivelata insufficienza che viene dallo Spirito (“vago tra raggi lontani/strappato ai raggi più semplici”). E che l’uscita dal dolore abbisogna d’altro dolore, in una consegna però che non assommando più ombre alle ombre le distingue, le chiama, ad ognuna ogni giorno dandole un volto. Quello ai propri occhi di una recuperata creaturalità la cui dignità nel carico è nella molteplicità delle mani, di un Dio che nel Figlio non cessa il suo scandalo. E di un Figlio che incontro all’origine mostra la strada:
“Per quelle parole: Perché mi hai abbandonato/Padre, Padre- e per la Madre in cordoglio/ho redento sulle Tue labbra/due parole più semplici: Padre nostro”.
Così nel poema Profili di Cireneo, del 1957 ma pubblicato in occasione della Domenica delle palme l’anno seguente (poco prima della sua elezione a vescovo di Cracovia), possiamo addentrarci col futuro Papa sul luogo dove la sequela, ogni sequela ha compimento e inizio, sul Golgota individuando in Simone di Cirene, nella gradualità della sua risposta e nella corrisposta consapevolezza, la figura della possibile salvazione a fronte d’ogni oscurità di rigetto.
La salita allora verso la città di Dio nel mistero pasquale di Cristo, nel segno concreto e riflesso della parola evangelica (Mc 10,32-34; Mt 16,24-25), avviene allora in queste pagine secondo una spinta, un insufflato affollarsi (soldati, donne, bambini) in cui ” tutti si aggirano ai confini di Dio” ed in cui allora nel montaggio quasi teatrale della scena (non dimentichiamo di Wojtyla, nella formazione, la scrittura di provenienza) la difficoltà di scorgere tra i profili le singole individualità è abilmente sciolto dall’interrogazione delle domande su di sé che loro stessi si pongono.
Ma chi è intanto quest’uomo dal cui sguardo le riflessioni ci investono? Ancora il sacerdote, il poeta, l’uomo oppure uno tra i tanti del Calvario, il salvabile, il salvato, il terzo che iniziando a osservare è già investito, a sé, anche di sé Cireneo? Nell’urgenza di una domanda che è stata scossa nella disperante solitudine che sempre rimanda a se stessi, il buio inizia forse già a rompersi nel vortice sì di quella memoria in cui con lo stesso Simone e la Maddalena siamo chiamati a entrare.
Quali passi li hanno condotti (lui che di lì vedrà il cielo, lei il cui piede sarà il primo a entrare nel sepolcro), ci hanno condotti tra quelle grida, tra quei riflessi di “ogni angolazione possibile”? La vita da quel lastrico (termine qui più volte replicato), da quella superficie di sofferenza e polvere su cui l’uomo è provato (nelle orecchie dal palazzo, nel palazzo, anche, da ogni Pilato) assume allora il solo profilo che “ininterrottamente” potrà continuare a parlarci, e a piegarci nell’espressione di una coscienza che sempre ha inizio e si muove “accanto all’altro Uomo”.
Là dove l’altro, l’Altro “è supremamente se stesso” perché “meno indifeso” nel movimento d’uomo e Dio in verticale.
Eppure come in ogni tempo, là sopra qualcosa di incompiuto, un senso, un pensiero sembra confondere tanto accalcare. Una tensione cui la poesia nella preghiera fatica l’indagine. I quattordici profili che ci vengono restituiti alla lente di un’invocazione sempre presente nei dati e nelle determinazioni storiche dei suoi riferimenti ha allora nel lampo verticale che quel lastrico va a spaccare l’indicazione di un invito, di una rinnovata (perché eterna) ed aperta speranza nella comprensione e nell’interruzione del ma.
Non ancora Cirenei, forse prossimi, nella difficoltà come noi di una contemporaneità bloccata tra desiderio e perdita, la parola agisce accompagnando e facendo affiorare dalle paralisi delle aspirazioni tratti e motivi delle singole identità ferite. Ed in cui appare evidente nella sordità delle disperazioni un movimento che dal sapersi fermi nella pastoia dei ragionamenti, ha nel presagio della profondità di una vita che non ha termine in noi l’inizio della sua fuoriuscita alla luce di una fragilità accolta e portata nella gradazione di una febbre che non ha perno nelle nostre vicende.
“Colui che lo é/neppure lui trova amore”. Anche noi con la ragazza delusa nella sua passione, o con lo schizoide, col gruppo dei ciechi, nella spinta di questa riflessione possiamo finalmente dirci entro una tensione che non nella nostra impazienza ma nel tempo di Dio pone il suo rischio, ed il suo affidamento in mali che, ora impariamo a conoscerli, non sono più solo nostri.
Che ( pur “se ogni passo ci costa”) anche nella oscurità può esserci gioia, che la partecipazione alla sofferenza di Cristo, semplicemente portando “sull’uguale distanza delle ore” ognuno la propria esile struttura come ricorda il grande polacco, è partecipare, nella graduale, in Lui, ricomposta consapevolezza a figli, alla stessa fiducia nel Padre.
In un’acquisizione data nella sapienza della poesia per aleggiamento, in versi in cui l’uomo di Nazareth non è mai nominato, semmai echeggiato tra i ricordi e le rovine, gli stupori e le cadute di esistenze che nella sequela dei reciproci richiami vanno a sollevarsi, a sollevarlo frammento per frammento dall’alto di un tralcio che per sempre nella Croce riandrà a saldare l’antica promessa nella confidenza d’abbraccio della terra.
Nella misericordia delle passioni toccate, dell’emoroissa, di Marta e Maria (di Lazzaro) e di tutti gli uomini e donne, di questi uomini e donne, attori, ombre, operai, tra le piaghe delle proprie siccità e insufficienze (scoramenti, melanconie, orgogli di bastevoli visioni) è da questa levata attrazione il volto di un movimento che ha nel riconoscimento e nel carico del proprio reciproco travaglio lo spostamento da una storia condannata e tradita ad una nella sua possibilità di pienezza nella ricostituzione di uno sguardo (“pietà che penetra, che vede” suggerirebbe Luzi) dischiuso alla sua eterna bellezza.
Qui la poesia che non a caso va a chiudere proprio con Simone di Cirene, nell’inquietudine di un agire tra ingiunzioni del potere e un salire via via illuminato entro la Pupilla di chi nel cui peso non c’è distinzione, qui la poesia dicevamo, sulla soglia di un mondo più “vasto, aperto (..) in cui ognuno trova il suo spazio”, si ferma nell’arco proprio di un mistero in cui la sua parola, in quanto umana, proprio qui dove nella sua preghiera si compie, nella sua misura ci affida.
Poi, lo sappiamo, è il silenzio del sabato, di una genesi che apparirebbe interrotta se l’invito all’andare iscritto sul lastrico non recasse in sé, nella sua incarnazione, il motivo di una relazione che Cristo ricostruendola, all’alba del terzo giorno nella sua luce andrà a spalancare.
Sarebbe la morte, sarebbe un inganno, quell’inganno contro la cui negazione, sempre più pericolosamente riflessa, e incalzante tra le maglie e i drammi di una modernità lontana dal sacro e dall’uomo, Giovanni Paolo II° nel suo pontificato, fino all’ultimo giorno, andrà ad operarsi, verso la Croce, nella Croce il presente grato di una Parola che nella sua memoria ha in Maria, la prima, la sua certa ascensione.