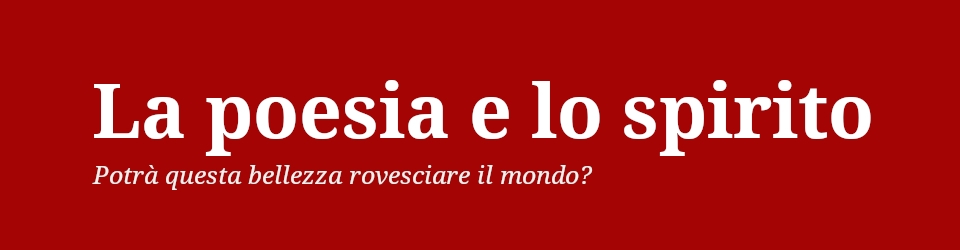di Giulio Bruno
Un thriller teologico, oggetto di aspre critiche da una parte del mondo cattolico.
“La lotta per il potere è appena iniziata” recita la locandina del film Conclave, diretto da Edward Berger e tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris. E non c’è dubbio che la struttura narrativa di Conclave sia incentrata su una tale lotta e appaghi l’aspettativa dello spettatore di fruire di un racconto cinematografico ricco di suspense e di colpi di scena: considerato il tema forse principale che viene trattato, Conclave può essere considerato un thriller teologico, anche se la definizione è inevitabilmente non esaustiva rispetto ai contenuti proposti. Non manca del resto neanche un sorprendente finale, peraltro alquanto anomalo, ove si tenga conto dei tradizionali valori e della storia della Chiesa cattolica – e che, in definitiva, attiene ad altro importante tema del film.
Conclave ha suscitato aspre critiche in alcuni ambienti ecclesiastici ed accademici. Per esempio, Per il cardinale Gerhard Müller – prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede sino a metà 2017 (quando Papa Francesco lo sostituì con il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer) e, negli ultimi anni, uno dei più critici oppositori interni di Papa Bergoglio – “è un film di propaganda molto anti-ecclesiale e anti-cristiano che avrebbe potuto essere prodotto ai tempi di Hitler o Stalin“[1]. Per Regis Martin, “il film è in realtà è un atto di sovversione, non solo dell’ordine della natura, ma della grazia stessa, in particolare la grazia di Dio Onnipotente nel darci una Chiesa armata di sufficiente certezza che quando parla è Gesù stesso che sentiamo.”[2] Per padre Raymond J. de Souza, “si tratta di una sfida frontale per una Chiesa che propone dei credi – e li prega ogni domenica – e pubblica un catechismo universale”.[3]
La figura del cardinale decano Thomas Lawrence e i due temi principali del film.
Il regista Edward Berger – il suo precedente film ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’ vinse quattro premi Oscar nel 2023 – in merito alla eventuale esistenza, in generale, di un suo stile personale, ha parlato di “prospettive ristrette”: come spiegato da alcuni siti internet, tutto lo sforzo creativo si concentrerebbe in una grande soggettività che va a focalizzarsi sul protagonista. La struttura narrativa di Conclave è coerente con tale dichiarazione: in effetti, la figura del cardinale Thomas Lawrence (magistralmente interpretato da Ralph Fiennes), protagonista principale del film, incaricato del coordinamento del Conclave per l’elezione del nuovo pontefice in ragione della sua veste di decano del collegio cardinalizio, è centrale nella narrazione filmica e nella generazione dei principali significati racchiusi nel film. E ciò sia per l’incidenza, sull’esito del conclave, delle iniziative da lui responsabilmente intraprese, sia per gli alti valori morali nei quali, uomo integerrimo, crede con fermezza e che ispirano la sua condotta, finalizzata, durante tutta la durata del Conclave, a consentire la elezione del cardinale più meritevole, indipendentemente dalle logiche di potere, sia per il genuino tormento interiore che lo caratterizza. È per mezzo della sua figura che viene trattato il tema fondamentale del rapporto fede – dubbio. Le idee proposte al riguardo costituiscono il principale motivo delle aspre critiche di cui si diceva sopra, per via dell’omelia pronunciata da Lawrence.
Un secondo importante tema – il ruolo della donna nella società e nella Chiesa – è introdotto gradualmente attraverso la presenza premurosa, discreta e silenziosa, ma al tempo stesso vigile, delle suore, che crea un’atmosfera di soffusa spiritualità, un’aura di sacralità. La compostezza, il riserbo e la religiosa sobrietà delle suore stride, con una intensità che va accrescendosi nel corso del film, con il clima sempre più teso e insidioso, talora chiassoso e rissoso, che si instaura tra i cardinali.
(Continua)
[1] Cardinal Müller Calls ‘Conclave’ Film Hitlerian ‘Anti-Christian Propaganda’?, articolo di Edward Pentin,Senior Contributor del Register e EWTN News Vatican Analyst.
[2] Regis Martin è professore di teologia e docente associato presso il Veritas Center for Ethics in Public Life presso la Franciscan University di Steubenville, Ohio. Il passo citato, tradotto dall’inglese, è tratto da Conclave’ Snubbed at the Oscars — And It Won’t Win Any Awards for Accuracy Either.
[3] Padre Raymond J. de Souza, founding editor of Convivium magazine. Il passo citato, tradotto dall’inglese, è tratto dall’articolo ‘Conclave’ Cardinal’s Homily Mirrors Some of Pope Francis’ Actual Words.